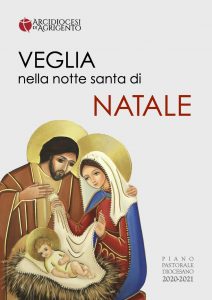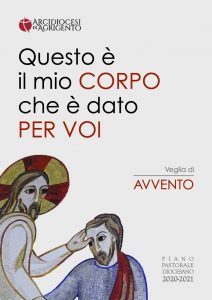La Lettera Pastorale dell’Arcivescovo — “Nel tempo della prova, l’audacia della speranza” — suggerisce, come di consueto, il tema, l’obiettivo e la proposta operativa del Piano Pastorale Diocesano. Un Piano Pastorale che, oltre a tenere conto della particolare situazione che stiamo vivendo per via della pandemia, la assume come un “segno dei tempi”.
La Lettera Pastorale dell’Arcivescovo — “Nel tempo della prova, l’audacia della speranza” — suggerisce, come di consueto, il tema, l’obiettivo e la proposta operativa del Piano Pastorale Diocesano. Un Piano Pastorale che, oltre a tenere conto della particolare situazione che stiamo vivendo per via della pandemia, la assume come un “segno dei tempi”.
Definire segno dei tempi questa situazione non significa certo credere che il Signore l’abbia voluta. Vuol dire piuttosto approfittarne — nel senso più positivo dell’espressione — come un’opportunità, da cui possiamo ricavare un bene più grande. In fondo, come un chiaroscuro in cui le ombre rivelano la luce che le definisce, ci sta costringendo a ritrovare tanti aspetti dell’esistenza che forse abbiamo dato per scontati o a cui ci siamo talmente abituati, fino a non riconoscerne più l’importanza. Nella prospettiva dei segni dei tempi, di cui ci parla la Sacra Scrittura e che riecheggia nella tradizione vivente della Chiesa, questo tempo può diventare tempo benedetto e fecondo, se sapremo viverlo con un atteggiamento illuminato dalla fede, sospinto dalla speranza e intriso di carità. Questo, nel piccolo delle nostre famiglie e delle nostre comunità ecclesiali e civili, abbiamo cercato e stiamo cercando di fare un po’ tutti. E questo ci propone il nuovo Piano Pastorale, come impegno organico e condiviso della nostra Chiesa, in comunione con i nostri Vescovi Francesco e Alessandro.
Mentre il mondo si ferma — non solo nei lockdown più o meno generali, ma nel bisogno ancora più profondo di dare un senso a tutto ciò che sta avvenendo — anche noi, come Chiesa Diocesana, sentiamo l’esigenza di rallentare il cammino previsto dal progetto ecclesiale a lungo termine. Già due anni fa ci siamo concessi un tempo di “sosta e rilancio” per aspettare chi è rimasto indietro rispetto alle due tappe del Ripensare la Comunità e dell’Abitare la Comunità, in modo da raggiungere insieme quella del Vivere la Comunità. Così stiamo provando a recuperare il senso dell’Amare la Comunità, perché solo amandola sinceramente possiamo ripensarla, abitarla e viverla. Prima di procedere ancora in questa direzione, riconosciamo di avere il dovere prioritario di prenderci cura della comunità e di accompagnarla in questo particolarissimo momento storico, trasformando le emergenze che la preoccupano in occasioni che la rinnovano.
Scegliamo così di “Sostenere la Comunità”, nella consapevolezza che questo, in concreto, significa amarla: l’amore passa sempre dalla disponibilità a farsi carico delle debolezze dell’altro. Scegliamo di farlo con l’annuncio della speranza che «non delude» (Rm 5,5), nella quale già «siamo stati salvati» (Rm 8,24): solo in forza della speranza che è in noi, chi è più forte può sostenere chi è più debole (cf. Rm 15,1), in modo che tutti, ciascuno per la sua parte, sostengano tutti. Del resto, nessuno è così forte da non avere bisogno di nulla né così debole da non avere nulla da dare.
A tutti l’augurio di un buon cammino, nello stile di Gesù sulla strada di Emmaus!
don Giuseppe Agrò
Vicario episcopale per il Settore Est con delega alla Pastoral

NEL TEMPO DELLA PROVA, L'AUDACIA DELLA SPERANZA
Carissimi,
mentre mi accingo a scrivervi quella che potrebbe essere la mia ultima lettera pastorale — prima di compiere l’età in cui i vescovi rassegnano al Santo Padre le dimissioni dalla guida delle diocesi — tanti sentimenti affollano il mio cuore.
Sono anzitutto sentimenti di gratitudine: verso il Signore, che ci ha chiamati a fare insieme questo tratto di strada; e verso ciascuno di voi, con i quali ho condiviso la gioia e la fatica del cammino. Vorrei che a tutti arrivasse il mio abbraccio carico di affetto, simile a quello di un padre che si vede invecchiare, ma è fiero di vedere crescere i suoi figli per i quali ha speso la vita. Questo ho cercato di fare nei dodici anni che ho passato con voi, con le mie possibilità e i miei limiti, ma soprattutto nell’esercizio dei miei doveri di pastore, in obbedienza a Dio e al mandato della Chiesa.
A questi sentimenti di gratitudine si aggiungono quelli per il dono del Vescovo Coadiutore Alessandro, che Papa Francesco ci ha fatto per sostenermi in quest’ultimo pezzo di cammino e per succedermi nella guida della nostra Chiesa. Sono contento perché so già che vi lascerò in buone mani, ma soprattutto perché insieme stiamo avendo la possibilità di sperimentare il senso della successione apostolica, attraverso una consegna graduale e un accompagnamento reciproco. A lui rinnovo il mio e il nostro benvenuto e a tutti chiedo di accoglierlo nel nome del Signore, perché, nella comunione ecclesiale e nel dialogo con tutte le realtà che vivono e operano nel nostro territorio, possiamo continuare a costruire il Regno di Dio che va crescendo in mezzo a noi.
Sappiamo bene che questa crescita, nonostante sia accompagnata dalla provvidenza e dalla misericordia del Signore, non è per nulla facile. Nel corso di questi anni abbiamo cercato insieme di individuare le fragilità e le ferite del nostro corpo sociale ed ecclesiale, per farcene carico e riscattarle alla luce del Vangelo. Insieme abbiamo condiviso la preoccupazione per un territorio sempre più provato da vecchie e nuove povertà, spesso abbandonato a se stesso e facile preda dei poteri forti di turno. Abbiamo condiviso l’ansia per le persone e le famiglie che lo abitano, costrette ad affrontare problematiche e criticità di vario genere; ma anche per quelle che da questa terra vanno via o che vi approdano, alla ricerca di destini migliori. Abbiamo condiviso la necessità di rinnovare il volto e l’azione delle nostre comunità ecclesiali, per renderle sempre più capaci di inserirsi attivamente nel tessuto umano e sociale, superando il rischio del ripiegamento e della chiusura in se stesse.
Quest’anno, poi, alle preoccupazioni e alle ansie di sempre si è aggiunta la paura della pandemia e delle sue ricadute su tutti i versanti dell’esistenza umana, della convivenza sociale e della stessa vita ecclesiale. Il diffondersi vertiginoso del virus e l’enorme numero di vittime a livello mondiale ci ha ricordato che siamo vulnerabili e che nessuna certezza può farci sentire al sicuro: ha messo in ginocchio l’impianto economico, l’apparato produttivo, la rete sanitaria, il sistema scolastico, la trama delle relazioni interpersonali e le consuetudini quotidiane delle nostre comunità.
L’esperienza del lockdown ci ha colti impreparati e ci ha spiazzati, imponendoci scelte e rinunce — non sempre capite e condivise — che ci hanno fatto soffrire molto. Abbiamo dovuto rinunciare alle cose più essenziali di cui è intessuta la nostra vita: gli incontri e i contatti, il lavoro e la scuola, le feste e gli svaghi. Come cristiani ci siamo dovuti privare di cose altrettanto vitali: l’Eucaristia e gli altri sacramenti, la possibilità di recarci in chiesa e di ritrovarci con la comunità, la gioia di condividere i percorsi di fede e di ricevere il conforto dei pastori e del loro ministero, anche e soprattutto nei momenti più dolorosi come la malattia e la morte. La decisione di chiudere le chiese e di sospendere tutte le attività, prima ancora che decreti del Governo e disposizioni lo imponessero a tutto il territorio nazionale, è stata molto sofferta, ma si è resa necessaria per via della particolare povertà in cui versa la nostra provincia riguardo a strutture e risorse sanitarie.
Anche la ripartenza non è stata — e tuttora non è e continuerà a non essere — semplice, sia perché ricostruire è sempre difficile, sia perché il pericolo non è ancora scampato e non sappiamo quali risvolti dobbiamo ancora aspettarci. Anzi, la crescita della curva dei contagi, anche nella nostra provincia, sta facendo crescere l’allarme che nei mesi scorsi sembrava essere rientrato.
Una cosa tuttavia è certa ed è sotto gli occhi di tutti: la speranza non è mai venuta meno; anzi, quanto più la disperazione ha rischiato di prendere il sopravvento, tanto più la speranza è diventata tenace. La privazione ci ha fatto riscoprire l’importanza di tante cose che, nella quotidianità, forse davamo per scontate. La distanza da mantenere tra noi ci ha ricordato il valore della presenza, a cui non possiamo rinunciare nonostante le nuove opportunità offerte dal mondo digitale e dalla realtà virtuale. Il bisogno di reagire ha tirato fuori tante potenzialità nascoste e il bisogno di farcela a tutti costi ha stimolato la solidarietà verso chi non può farcela da solo.
Del resto, se la vita ordinaria delle nostre parrocchie sembra essersi fermata o anche solo rallentata, l’esercizio della carità nelle sue varie forme è stato il modo naturale con cui abbiamo continuato a vivere e ad annunciare il Vangelo, nonostante tutto. E anche le forme di comunicazione che ogni comunità ha attivato — pur con tutte le riserve legate al moltiplicarsi delle celebrazioni in streaming — sono il segno dell’esigenza irrinunciabile di esprimere e percepire la prossimità e l’appartenenza, mantenendo i rapporti e curando le relazioni, condividendo gli eventi della vita e le esperienze della fede, al di là di ogni possibile ostacolo e di qualsiasi impedimento.
Da questa speranza che non è disposta a cedere possiamo e dobbiamo ripartire. Anche perché essa è molto di più della voglia umana di non mollare e di guardare oltre: ha il suo fondamento incrollabile nella fede e la sua espressione più autentica nella carità.
L’icona evangelica dei Discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35), che è un racconto di speranza perduta e ritrovata, ci aiuterà a leggere questo tempo, mettendone in evidenza le contraddizioni e le prospettive; ci aiuterà inoltre a tracciare un itinerario che insieme proveremo a percorrere durante il nuovo anno liturgico-pastorale, con le modalità che l’evolversi della situazione e le disposizioni governative renderanno possibili.
La rinascita dall’alto, che lo scorso anno il dialogo tra Gesù e Nicodemo ci ha suggerito, richiede ora, nel tempo della prova, l’audacia della speranza, che ha riportato i due di Emmaus a Gerusalemme e che deve riportare anche noi sul sentiero della fede matura, della sequela coraggiosa e della testimonianza gioiosa.
Forza, dunque! È tempo di ripartire!
Il prezzo alto della speranza
L’evangelista colloca l’episodio dei discepoli di Emmaus «in quello stesso giorno». È «il primo giorno della settimana» (24,1) — quello della risurrezione — che segna per i discepoli l’inizio di un tempo nuovo, purché siano disposti ad accogliere la novità che Dio è capace di introdurre negli avvenimenti umani.
Se leggiamo attentamente il testo, ci rendiamo conto che è proprio questa disponibilità che inizialmente manca ai due discepoli: parlano della tomba vuota, della visione degli angeli e dell’annuncio della risurrezione, di ciò che le donne e i discepoli, andati al sepolcro, hanno riferito di aver visto e sentito; eppure loro stanno tornando indietro, col volto triste. Hanno constatato il fallimento delle loro aspettative, coinvolti nello svolgimento dei fatti, e subìto le ingiustizie del potere; e questo ha accorciato il loro sguardo e abbassato le loro attese.
La loro mancanza di fiducia forse è motivata dalla paura e dallo smarrimento, come si può intuire dai particolari del racconto; ma resta il fatto che proprio sul più bello, quando cioè avrebbero potuto avere la prova che ciò in cui speravano si stesse avverando, hanno deciso di ritornarsene a casa delusi. Una speranza corta, la loro. Sarebbero potuti restare, ma si sono ritirati, perché osare di più richiede uno sforzo tutt’altro che facile.
Questo particolare, offerto dal contesto della scena, ci ricorda che la speranza ha sempre un prezzo alto da pagare e deve fare i conti con le situazioni concrete della vita, non sempre favorevoli e a volte addirittura avverse. Ci ricorda che la speranza richiede un supplemento di pazienza e di perseveranza, insieme a una salda fiducia in Dio e nelle sue promesse, per guardare oltre ciò che si vede e attendere al di là di ciò che ci si aspetta. Se — come ai discepoli di Emmaus all’inizio del loro cammino di ritorno — questa disponibilità viene a mancare, la speranza si spegne. È un po’ la nostra condizione, oggi come sempre e forse più del solito: vorremmo continuare a sperare, ma sembra che non ce ne siano le ragioni; vorremo restare al punto dove siamo arrivati, sforzandoci di proseguire, ma è più facile girarci dall’altra parte e tirare i remi in barca.
Nel tempo della prova che stiamo vivendo, come «in quello stesso giorno», è necessario allungare lo sguardo e alzare le attese, senza cedere allo sconforto e alla rassegnazione. Solo così la paura e lo smarrimento, che come uomini avvertiamo nei momenti più bui dell’esistenza, si potranno trasformare nell’inquietudine di chi non smette mai di cercare e di andare avanti. Solo così potremo riconoscere il passaggio di Cristo nella storia, anche quando si nasconde dietro tanti avvenimenti di cui non capiamo il senso e che facciamo fatica ad accettare.
La direzione del cammino — ma soprattutto lo slancio del cuore — dei due discepoli cambia proprio quando riconoscono, nel viandante sconosciuto, Gesù stesso che si accosta a loro, per condividere le loro amarezze e raccogliere il residuo di speranza che filtra dal loro racconto. Dalla capacità di scorgere il passaggio di Cristo nelle nostre notti e dalla certezza che Lui può rendere possibile un nuovo giorno comincia l’uscita dalla notte per rinascere dall’alto, come vi ho scritto nella lettera pastorale dello scorso anno.
Ora è il momento favorevole perché questo possa avvenire! Se la notte si fa buia e se nessuna certezza umana sembra poterla rischiarare, dobbiamo sforzarci di guardare più a fondo. Anche noi ci accorgeremo che Lui continua a passare, perché ce lo ha promesso: «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20).
Il passaggio di Cristo nella storia umana
Il passaggio di Cristo nella storia umana è sempre un passaggio discreto, che rispetta, senza forzarli, i tempi della crescita e la libertà delle scelte di ciascuno. E tuttavia è un passaggio che, se accolto, non lascia indifferenti. È un passaggio che interpella a uscire fuori dai propri schemi e dalle proprie convinzioni, dalle proprie certezze e dalle proprie aspettative, per aprirsi a qualcos’altro, che può dare un senso inaspettato alla vita e una direzione nuova al cammino.
Le espressioni che l’evangelista utilizza per descrivere questo passaggio sulla strada di Emmaus ci aiutano a coglierne il significato e il valore, anche per noi oggi.
Si avvicinò e camminava con loro
Innanzitutto, Gesù «si avvicinò e camminava con loro». Questi due verbi esprimono la prossimità di Dio agli uomini e la condivisione della loro esistenza attraverso il mistero dell’incarnazione di Cristo. Il Vangelo è pieno di riferimenti che raccontano le modalità concrete con cui il Signore incontra la nostra umanità in tutti i suoi aspetti. L’incontro è una delle immagini più belle e rassicuranti della presenza di Dio in mezzo a noi. Egli non sta a guardare da lontano, ma si china per vedere le nostre povertà e prenderle su di sé, come, per esempio, fa il buon samaritano. E così ci indica lo stile con cui dobbiamo farci prossimi a chiunque incontriamo sulle nostre strade; ma, prima ancora, ci mostra come Lui si fa prossimo a noi. Nessuno può dare ciò che non ha: non possiamo avvicinarci autenticamente agli altri e camminare sinceramente con loro se non permettiamo a Cristo di avvicinarsi a noi e di camminarci accanto.
Sono tanti i modi con cui Lui si fa presente e ci chiede di essere riconosciuto. Lo fa con la Parola e con i Sacramenti, ma lo fa anche nell’esperienza della vita comunitaria e nell’incontro con ogni persona, soprattutto con i più bisognosi di attenzioni e di cure e con quelli che sono lasciati soli e ai margini della strada. Ci ha detto che è principalmente nei poveri e negli ultimi che vuole essere trovato, perché solo provando compassione nei loro confronti possiamo capire la compassione che Lui ha verso di noi; e solo traducendo questa compassione in gesti concreti di amore possiamo cogliere l’amore con cui Lui ci ama.
Fece come se dovesse andare più lontano
Dopo essersi intrattenuto e aver conversato con loro, «fece come se dovesse andare più lontano». Non dobbiamo intendere questo “andare più lontano” come una presa di distanza, ma come un tentativo di allargare l’orizzonte. Dio non si allontana neppure dai peccatori, ma continua a cercarli con amore di Padre. A maggior ragione lo fa con chi è disposto a seguirlo, ma che non è ancora pronto a lasciare la sua barca e le sue reti. A volte le nostre abitudini e le nostre sicurezze ci imprigionano, impedendoci di guardare oltre e di aprirci alla novità. Questo succede nell’esistenza di ogni giorno, come nel cammino della fede e nella vita della Chiesa, quando restiamo fermi nelle nostre posizioni e non accettiamo la sfida di rimetterle — e di rimetterci — in discussione.
Se Gesù fa come se dovesse andare più lontano, è solo perché vuole che noi, come i discepoli di Emmaus, gli diciamo con insistenza: «Resta con noi, perché si fa sera…». In questa richiesta c’è tutto il bisogno che abbiamo di Lui, quando ci rendiamo conto che da soli non possiamo farcela; ma a volte pretendiamo che Lui si adegui a noi, per restare tranquilli là dove ci troviamo, mentre Lui ci invita a proiettarci oltre. C’è la fatica di una conversione, di cui sentiamo l’esigenza, ma di cui a volte non abbiamo il coraggio. Non possiamo aspettarci che la luce di un nuovo giorno venga a rischiarare le tenebre delle nostre notti, se non ci decidiamo a osare di più, volgendo lo sguardo dove Cristo ci indica, anziché dove noi preferiamo trattenerlo.
Entrò per rimanere con loro
Per questo, alla richiesta di restare, Gesù «entrò per rimanere con loro». Ancora due verbi che esprimono, con maggiore forza, una prossimità che diventa rapporto intimo e una condivisione che si fa promessa di eternità. La volontà del Signore di dare un senso inaspettato alla nostra vita e una direzione nuova al nostro cammino è sempre più forte di ogni nostro tentativo di restare fermi nei nascondigli e nei rifugi sicuri che pensiamo di costruirci.
Non vi scandalizzate se vi dico che a volte questi nascondigli e questi rifugi sono anche i nostri modi di pensare e vivere la fede. Se — solo per fare un esempio — una delle preoccupazioni principali, in questo tempo di restrizioni a causa della pandemia, è “recuperare” i sacramenti che non abbiamo celebrato, senza però cogliere l’opportunità di compiere un serio cammino personale e comunitario di ricerca e di crescita, forse è perché abbiamo un po’ svuotato gli stessi sacramenti della loro portata esistenziale e li abbiamo ridotti a “cose” da dare e da ricevere.
Eppure, è proprio là, anche nelle nostre difficoltà a capire il senso di ciò che siamo e di ciò che facciamo, che Cristo è disposto a tornare per continuare a scuoterci, per non lasciarci soli e per trovare nuove opportunità di riscatto. Là continua a darci appuntamento e ad aspettarci, con pazienza e con perseveranza, perché sa che i nostri tempi non sono uguali per tutti e che ognuno di noi ha bisogno di sentirsi incoraggiato e di essere accompagnato, per crescere e maturare. E là vuole che sperimentiamo tutto questo, perché anche noi impariamo a usare le stesse accortezze con chiunque ci vive o anche soltanto ci passa accanto.
Sparì dalla loro vista
Alla fine, non appena i discepoli sono riusciti a riconoscerlo, Gesù «sparì dalla loro vista». Come prima — dopo essersi avvicinato e aver camminato con loro — aveva fatto come se dovesse andare più lontano, ora — dopo essere entrato per rimanere con loro — decide di scomparire. Sembra proprio strano il suo modo di agire, verrebbe da pensare. E forse, in effetti, un po’ lo è. Ma, se ci pensiamo bene, questo è il modo di agire di chi vuole educare e far crescere, rendendo adulti e quindi autonomi quanti sono affidati alle sue cure.
Per “essere” genitori non basta volere un figlio, metterlo alla luce e allevarlo. Occorre un altro passaggio, necessario quanto i precedenti: bisogna che i genitori lascino andare i loro figli, perché solo così permettono loro di essere ciò che devono diventare.
In fondo, è proprio questo che Gesù fa con i due di Emmaus… e con ciascuno di noi. Scompare, ma non se ne va; si fa da parte, ma non è assente. La sua è una presenza misteriosa — come diciamo con il linguaggio della teologia — perché vuole che lo riconosciamo in ciò che ci ha mostrato e si aspetta che, a nostra volta, rendiamo visibile e tangibile la sua vicinanza nascosta. A volte ci sembra che Dio sia lontano e che non si curi di noi; ma è soprattutto in questi momenti che, misteriosamente, ci sta aiutando a diventare adulti, nella fede e nella vita.
Lo stile di un passaggio che continua
In questo cammino di crescita e di maturazione, Cristo non ci abbandona a noi stessi e alle nostre iniziative, ma ci indica uno stile nuovo, che l’evangelista tratteggia intercalando i quattro tempi del suo passaggio sulla strada di Emmaus con alcuni atteggiamenti e alcuni gesti particolarmente significativi.
Accoglienza
In primo luogo, quando si avvicina ai due discepoli, li lascia parlare, mostrando una piena e rispettosa accoglienza del loro sfogo, della loro inquietudine e della loro delusione. Approfitta del fatto che non l’hanno riconosciuto e fa finta di non sapere, in modo che possano raccontare e ricostruire tutto, senza tralasciare nulla. Questo parlare liberamente li aiuta a prendere coscienza di quanto è accaduto, a fare chiarezza sulle loro aspettative, a manifestare i loro dubbi e i loro bisogni. Li aiuta a formulare chiaramente una precisa domanda di senso, a partire dal racconto del loro vissuto concreto e al di là delle teorie sulla vita e sulla fede. Ed è proprio questo che li dispone ad accogliere altrettanto liberamente le risposte che Lui è pronto a dare.
Non ci può essere vera accoglienza se non si dà all’altro la possibilità di esprimere liberamente tutto ciò che si agita nel suo cuore, senza preconcetti, pregiudizi o risposte preconfezionate. Ma se, da una parte, sentiamo tutti il bisogno di essere ascoltati e capiti, dall’altra, non sempre siamo disponibili ad ascoltare e a capire gli altri. Questo tratto fondamentale dell’atteggiamento di Gesù deve caratterizzare sempre più lo stile delle nostre comunità, perché l’annuncio del Vangelo rischia di restare sterile, se non si aggancia alla vita e se non diventa risposta mirata a domande reali.
Parola
Dopo aver fatto parlare i due discepoli, Gesù comincia a spiegare loro il senso delle Scritture in riferimento a Lui. La sua risposta parte dalle loro domande, ma le pone sotto un’angolatura diversa e le apre a una prospettiva più ampia. Fino a quando i due parlano tra loro, non riescono a fare altro che piangersi addosso, perché continuano a guardare le cose dal loro punto di vista ristretto e questo li soffoca. Gesù alza il livello della conversazione, accompagnando passo dopo passo i due discepoli a una comprensione sempre più profonda. E questo provoca in loro il bisogno di continuare a cercare, anche se non tutto si fa subito chiaro.
Ricentrarsi sulla Parola di Dio è essenziale per illuminare il mistero della vita, ritrovare le ragioni della speranza e cambiare la direzione del cammino. Sappiamo bene che per noi il contatto con la Parola è vitale, ma spesso questo contatto si limita a una lettura superficiale o a una conoscenza più o meno approfondita del testo in sé, senza riscontri e ricadute nell’esistenza. Anche le nostre catechesi a volte rischiano di perdere la freschezza dell’annuncio, se non ci aiutano a leggere la nostra vita con occhi diversi. Quanto più perdiamo il senso dell’orientamento, tanto più abbiamo bisogno di recuperare il primato della Sacra Scrittura nella nostra ricerca e nella nostra testimonianza personale e comunitaria. E anche sotto questo aspetto occorre ripensare lo stile delle nostre comunità, ora più che mai.
Eucaristia
Ma c’è un altro primato, direttamente collegato a quello della Parola, che per noi è ugualmente fondamentale: il primato dell’Eucaristia. È nel segno del pane spezzato e condiviso che i discepoli di Emmaus riconoscono Gesù, perché nel gesto sacramentale possono rifare l’esperienza di quel dono che ha cambiato la loro vita. Fin dalla primissima comunità cristiana l’Eucaristia è il fondamento della vita nuova, da cui tutto parte e a cui tutto ritorna. Ma a condizione che non sia soltanto un gesto esteriore, bensì un incontro che rinnova realmente l’esistenza, attraverso la partecipazione al mistero di Cristo che si comunica a noi.
Partecipando a questo mistero — e non soltanto assistendo al rito, sia “in presenza” sia “on line” — impariamo a riconoscere nelle mense delle nostre abitazioni il prolungamento della mensa eucaristica, dove il dono ricevuto diventa dono da offrire, in tutte le forme che le situazioni e le circostanze, ma soprattutto le persone che incontriamo, di volta in volta richiedono. Lo stile delle nostre comunità, rinnovato in chiave eucaristica, deve portarci a ridimensionare il numero delle celebrazioni — che a volte, nello stesso territorio e soprattutto nei mezzi della comunicazione, ci disorienta e ci separa — e a curarne piuttosto la comprensione autentica e la partecipazione consapevole, in modo che tutte le nostre scelte e le nostre azioni si ispirino al modello che l’Eucaristia ci offre.
Annuncio
C’è infine un ultimo elemento che il racconto di Emmaus mette in evidenza. Dopo aver incontrato e riconosciuto Gesù, mentre il loro cuore continua ad ardere nel ricordo di quanto hanno vissuto, i due discepoli invertono la rotta del loro ritorno e si rimettono sulla via della testimonianza. Ritrovano la comunità, da cui avevano preso le distanze, e prima di tutto ai fratelli nella fede annunciano quanto hanno sperimentato. E poi — anche se il testo non lo dice, ma vogliamo immaginarlo — insieme alla comunità continuano a raccontare a tutti ciò che è accaduto loro, perché chiunque abbia la possibilità di fare la loro stessa esperienza.
L’annuncio sgorga dal cuore e non è altro che il racconto di tutto ciò che Dio ha compiuto in noi, da quando ci ha raggiunti nel nostro sconforto a quando ha risvegliato la nostra speranza. Non è la ripetizione di concetti che abbiamo appreso, ma l’opportunità di fare con gli altri ciò che Cristo ha fatto con noi. Perché è attraverso di noi — come vi dicevo prima — che continua a rendersi visibile, anche quando la sua presenza resta nascosta. Lo stile delle nostre comunità ha bisogno di recuperare anche questa dimensione, perché solo una speranza audace fino a questo punto può risollevare le sorti dell’umanità, soprattutto in questi tempi di prova e di incertezza.
Accoglienza, Parola, Eucaristia e Annuncio aprono così quattro direzioni che quest’anno seguiremo per rilanciare il nostro cammino ecclesiale. Il Piano Pastorale Diocesano ci aiuterà a definire meglio queste direzioni e a percorrerle insieme. Ovviamente dovremo tenere conto dei risvolti della pandemia per pensare e compiere le nostre azioni, ma sono certo che le nostre comunità, con il supporto degli organismi diocesani, saranno all’altezza della situazione e continueranno a essere per il nostro territorio fari di luce e dispensari di speranza.
Per questo e per tutto vi benedico, vi affido a Maria e ai nostri Santi patroni e vi assicuro la mia preghiera e la mia vicinanza.
Agrigento, 15 novembre 2020
XXXIII Domenica del Tempo Ordinario – IV Giornata mondiale dei Poveri
✠ don Franco, Vescovo
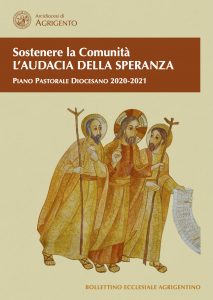
SOSTENERE LA COMUNITÀ
1. In continuità con il cammino compiuto, ma in un contesto nuovo
La Chiesa che vive nel tempo, radicata nella vita dello Spirito del Risorto, sempre si pone in ascolto di Dio e dell’uomo per cercare di rispondere alla propria vocazione. Essa, «fornita dei doni del suo fondatore e osservando fedelmente i suoi precetti di carità, umiltà e abnegazione, riceve la missione di annunciare e istaurare in tutte le genti il regno di Cristo e di Dio, e di questo regno costituisce in terra il germe e l’inizio» (Lumen Gentium 5).
All’inizio di un nuovo anno, la Chiesa Agrigentina rinnova il suo impegno di ascolto e il suo slancio missionario, per annunciare il Vangelo e promuovere il bene della persona, della famiglia e della comunità, favorendo la sinergia tra tutte le espressioni della vita ecclesiale e la collaborazione con le varie realtà extra-ecclesiali presenti e operanti nel territorio.
In continuità con il cammino tracciato dall’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium (24 novembre 2013) di Papa Francesco, dal Documento-base Verso un nuovo volto delle comunità ecclesiali nella Chiesa Agrigentina (12 novembre 2016) e dai precedenti Piani Pastorali Diocesani, il PPD 2020-2021 ripropone l’esigenza di continuare il ripensamento della presenza e dell’azione delle comunità ecclesiali nel territorio. La continuazione di questo ripensamento, tuttavia, non può non tener conto del nuovo contesto che si è venuto a creare con il diffondersi della pandemia e con le sue ricadute nella vita sociale, economica e politica delle nostre comunità.
La pandemia non solo ci ha rinchiusi in uno spazio circoscritto, ma ci ha obbligati anche a ripensare la nostra azione pastorale e le nostre modalità di presenza nel territorio, costringendoci a rivedere il nostro impianto pastorale ordinario su cui abbiamo speso risorse ed energie. Nell’omelia per la Messa Crismale dello scorso 27 maggio, l’Arcivescovo Francesco ci ha parlato di un “tempo fuori dal solito” e di un “tempo di anomalie e paradossi”, che ci interpella a rimettere tutto in discussione, a partire da noi stessi, dal nostro posto nel mondo e dal nostro ruolo nella vita ecclesiale e sociale.
Più volte Papa Francesco, descrivendo il nostro tempo come “epoca di crisi”, ha affermato che è in corso una vera e propria “crisi epocale”, non solo per la messa in discussione dei valori tradizionali e delle istituzioni che su questi valori si fondano, ma per il cambiamento della stessa autocomprensione dell’uomo e della sua visione del mondo. Nel messaggio per la benedizione Urbi et Orbi del giorno di Pasqua, il Santo Padre ha parlato inoltre di “sfide epocali”, che richiedono alla comunità cristiana di portare a tutti il “contagio della speranza”, agendo decisamente contro l’indifferenza, gli egoismi, le divisioni e la dimenticanza.
Nella Lettera Pastorale l’Arcivescovo ci chiede di ripartire proprio dalla «speranza che non è disposta a cedere» e ci indica l’icona evangelica dei Discepoli di Emmaus — quale «racconto di speranza perduta e ritrovata» — per «leggere questo tempo, mettendone in evidenza le contraddizioni e le prospettive». Solo su questo fondamento e sui suoi risvolti concreti potremo continuare a portare avanti il progetto ecclesiale a lungo termine nel quale ci siamo impegnati negli ultimi anni.
La pandemia intesa come un vero e proprio “segno dei tempi” — insieme a tanti altri fenomeni che caratterizzano l’attuale contesto socio-culturale — potrebbe diventare lo spartiacque non solo di un “prima” e di un “dopo”, ma anche di uno stile che come Chiesa acquisiamo per continuare il nostro cammino.
In questa situazione di precarietà, lo Spirito non ha smesso di agire e di sorprenderci. L’ha fatto in particolare con la scelta di Papa Francesco di inviare mons. Alessandro Damiano, Vicario generale di Trapani, come Arcivescovo Coadiutore nella nostra Chiesa Agrigentina. Mentre lo accogliamo tra noi, ci disponiamo a riprendere il nostro cammino nel segno della continuità e della novità, con la certezza che è il Signore stesso a condurci in mezzo alle vicende imprevedibili della storia.
2. La prosecuzione del cammino
Su questo sfondo, il PPD 2020-2021 si pone il seguente OBIETTIVO GENERALE:
le comunità locali e tutte le altre espressioni della vita ecclesiale sono invitate
- a rileggere la propria storia partendo dalla consapevolezza delle proprie fragilità e delle proprie potenzialità,
- a lasciarsi interpellare dalla Parola del Vangelo,
- a riconoscere Cristo nello spezzare il pane
- e a ripartire per annunciarlo risorto dai morti.
«Accoglienza, Parola, Eucaristia e Annuncio — ci dice don Franco nella sua Lettera — aprono così quattro direzioni che quest’anno seguiremo per rilanciare il nostro cammino ecclesiale. Il Piano Pastorale Diocesano ci aiuterà a definire meglio queste direzioni e a percorrerle insieme».
3. La proposta operativa
L’evoluzione della situazione pandemica e il susseguirsi dei provvedimenti governativi per il contenimento del contagio ha inciso profondamente sull’organizzazione della vita ordinaria delle nostre comunità e, quasi sicuramente, richiederà continui adattamenti anche durante il nuovo anno. Per questo motivo è più opportuno pensare a una proposta operativa flessibile, che si andrà modulando progressivamente, tenendo tuttavia presente l’obiettivo generale e l’articolazione complessiva delle tappe intermedie, riportata più avanti.
Compatibilmente con le possibilità che si andranno via via delineando, preferiremo gli incontri “in presenza” sia per la condivisione dei percorsi di fede sia per la formazione degli operatori pastorali sia per l’attività degli organismi di partecipazione. Qualora ciò non fosse possibile — e comunque in maniera complementare per supportare l’azione delle comunità ecclesiali nel territorio — il Dipartimento unico per la Pastorale e la Ministerialità elaborerà e metterà a disposizione appositi strumenti liturgici, catechetici e formativi, su supporti stampabili e multimediali condivisi nella sezione “Piano Pastorale Diocesano” del sito web dell’Arcidiocesi (http://www.diocesiag.it/piano-pastorale-diocesano/), adattandoli alle situazioni che si verranno a creare durante l’anno.
Per l’elaborazione di questi strumenti il Dipartimento si avvarrà della collaborazione di apposite equipe, costituite da presbiteri e laici dei tre Settori dell’Arcidiocesi.
Per ogni tappa del PPD, gli strumenti prevederanno tre sezioni:
- sezione biblica ➝ approfondimento della Liturgia della Parola domenicale e festiva;
- sezione liturgica ➝ liturgie familiari da celebrarsi in casa prima o dopo aver partecipato all’Eucaristia (o, in caso di lockdown, al posto dell’Eucaristia);
- sezione esistenziale ➝ proposta di percorso per fasce:
-
- completamento dell’Iniziazione Cristiana,
- giovani,
- fidanzati,
- sposi nei primi anni di vita matrimoniale,
- sposi in preparazione al battesimo dei figli,
- sposi nell’accompagnamento post-battesimale dei figli,
- sposi nelle fasi successive della vita matrimoniale,
- famiglie ferite e in situazioni di fragilità,
- adulti (single e vedovi),
- presbiteri e diaconi, religiosi e religiose.
Attraverso questi strumenti ci sforzeremo di riscoprire la nostra identità cristiana e l’impegno che ne deriva:
- nel contesto familiare vissuto come “piccola Chiesa domestica”;
- nella comunità ecclesiale intesa come «la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie» (Christifideles laici, n. 26);
- nella vita del presbiterio, degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, al servizio dell’intero corpo ecclesiale;
- nell’esperienza associativa delle aggregazioni laicali e dei loro percorsi specifici.
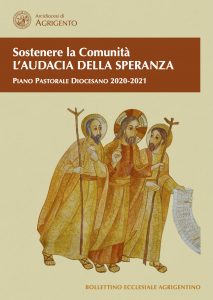
TAPPE 2020-2021
Considerando che:
l’anno pastorale coincide con l’anno liturgico e la sua articolazione è determinata dal tempo della Chiesa;
l’obiettivo generale suggerisce una progressione di tappe e obiettivi intermedi, che si prestano alla scansione temporale dei tempi liturgici;
per ciascuna di queste tappe e per i relativi obiettivi intermedi, l’Arcivescovo — nella sua Lettera Pastorale — ci fornisce alcune chiavi di lettura e alcune esortazioni utili per il cammino unitario delle nostre comunità;
la proposta operativa, che il Dipartimento per la Pastorale e la Ministerialità andrà definendo in corso d’opera e che ogni comunità locale con i suoi organismi di partecipazione adatterà al proprio contesto, è la seguente:
Prima tappa - ACCOGLIENZA
Avvento / Natale / Tempo Ordinario (I)
«Si avvicinò e camminava con loro» (Lc 24, 15)
Obiettivo intermedio:
Rileggere la propria storia partendo dalla consapevolezza delle proprie fragilità e delle proprie potenzialità.
Magistero dell’Arcivescovo (dalla Lettera Pastorale):
«Non ci può essere vera accoglienza se non si dà all’altro la possibilità di esprimere liberamente tutto ciò che si agita nel suo cuore, senza preconcetti, pregiudizi o risposte preconfezionate. Ma se, da una parte, sentiamo tutti il bisogno di essere ascoltati e capiti, dall’altra, non sempre siamo disponibili ad ascoltare e a capire gli altri. Questo tratto fondamentale dell’atteggiamento di Gesù deve caratterizzare sempre più lo stile delle nostre comunità, perché l’annuncio del Vangelo rischia di restare sterile, se non si aggancia alla vita e se non diventa risposta mirata a domande reali».
Riferimento al tempo liturgico:
La prossimità di Cristo, celebrata nell’attesa e nell’accoglienza del mistero dell’incarnazione, è terapeutica per le tante ferite lasciate dalle delusioni delle vita personale e comunitaria.
Indicazioni operative:
Aiutare la comunità e i suoi membri a guardarsi dentro e a raccontare il proprio vissuto, come punto di ripartenza per un nuovo tratto di cammino da compiere insieme.
Seconda tappa - PAROLA
Quaresima
«Spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui» (Lc 24, 27)
Obiettivo intermedio:
Lasciarsi interpellare dalla Parola del Vangelo.
Magistero dell’Arcivescovo (dalla Lettera Pastorale):
«Ricentrarsi sulla Parola di Dio è essenziale per illuminare il mistero della vita, ritrovare le ragioni della speranza e cambiare la direzione del cammino. Sappiamo bene che per noi il contatto con la Parola è vitale, ma spesso questo contatto si limita a una lettura superficiale o a una conoscenza più o meno approfondita del testo in sé, senza riscontri e ricadute nell’esistenza. Anche le nostre catechesi a volte rischiano di perdere la freschezza dell’annuncio, se non ci aiutano a leggere la nostra vita con occhi diversi. Quanto più perdiamo il senso dell’orientamento, tanto più abbiamo bisogno di recuperare il primato della Sacra Scrittura nella nostra ricerca e nella nostra testimonianza personale e comunitaria. E anche sotto questo aspetto occorre ripensare lo stile delle nostre comunità, ora più che mai».
Riferimento al tempo liturgico:
La Quaresima rimette la Chiesa nell’atteggiamento dell’ascolto, a partire da una domanda e da una ricerca che riaprono incessantemente il cammino dell’esodo, cioè dell’uscita da sé verso l’orizzonte tracciato dalla Parola di Dio.
Indicazioni operative:
Aiutare la comunità e i suoi membri a formulare — partendo dal racconto del proprio vissuto — domande di senso che possano riaprire un itinerario di incontro e di dialogo con Cristo, alla luce della sua Parola.
Terza tappa - EUCARISTIA
Pasqua
«Prese il pane, […] lo spezzò e lo diede loro» (Lc 24, 30)
Obiettivo intermedio:
Riconoscere Cristo nello spezzare il pane.
Magistero dell’Arcivescovo (dalla Lettera Pastorale):
«Partecipando a questo mistero […] impariamo a riconoscere nelle mense delle nostre abitazioni il prolungamento della mensa eucaristica, dove il dono ricevuto diventa dono da offrire, in tutte le forme che le situazioni e le circostanze, ma soprattutto le persone che incontriamo, di volta in volta richiedono. Lo stile delle nostre comunità, rinnovato in chiave eucaristica, deve portarci a ridimensionare il numero delle celebrazioni — che a volte, nello stesso territorio e soprattutto nei mezzi della comunicazione, ci disorienta e ci separa — e a curarne piuttosto la comprensione autentica e la partecipazione consapevole, in modo che tutte le nostre scelte e le nostre azioni si ispirino al modello che l’Eucaristia ci offre».
Riferimento al tempo liturgico:
La comunità cristiana, nata dalla Pasqua di Cristo, trova il suo centro nell’Eucaristia, che diventa per i battezzati scuola di vita nuova, in cui si sperimenta la comunione e ci si prepara alla missione.
Indicazioni operative:
Aiutare la comunità e i suoi membri a riscoprire nell’Eucaristia il crocevia in cui incontrare e riconoscere Dio come Padre e gli altri, in Cristo, come fratelli.
Quarta tappa - ANNUNCIO
Tempo Ordinario (II)
«Partirono senza indugio e […] narravano» (Lc 24, 33-35)
Obiettivo intermedio:
Ripartire per annunciare Cristo risorto dai morti.
Magistero dell’Arcivescovo (dalla Lettera Pastorale):
«L’annuncio sgorga dal cuore e non è altro che il racconto di tutto ciò che Dio ha compiuto in noi, da quando ci ha raggiunti nel nostro sconforto a quando ha risvegliato la nostra speranza. Non è la ripetizione di concetti che abbiamo appreso, ma l’opportunità di fare con gli altri ciò che Cristo ha fatto con noi. Perché è attraverso di noi […] che continua a rendersi visibile, anche quando la sua presenza resta nascosta. Lo stile delle nostre comunità ha bisogno di recuperare anche questa dimensione, perché solo una speranza audace fino a questo punto può risollevare le sorti dell’umanità, soprattutto in questi tempi di prova e di incertezza».
Riferimento al tempo liturgico:
La quotidianità, rinnovata dalla celebrazione dei misteri di Cristo, è il tempo fecondo dell’annuncio della fede e della testimonianza della speranza.
Indicazioni operative:
Aiutare la comunità e i suoi membri a raccontare quanto Dio ha compiuto per il suo popolo attraverso l’opera del Figlio e dello Spirito Santo, manifestata nelle Scritture e resa presente nell’Eucaristia.
Sussidio per il Tempo Ordinario [II] (quarta tappa / 2)
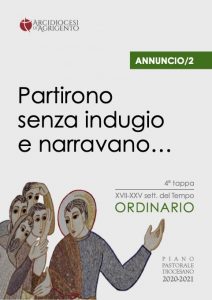
Sussidio-per-il-Tempo-Ordinario-II-2
Sussidio-per-il-Tempo-Ordinario-II-2-impaginato-per-la-stampa
Sussidio per il Tempo Ordinario [II] (quarta tappa / 1)
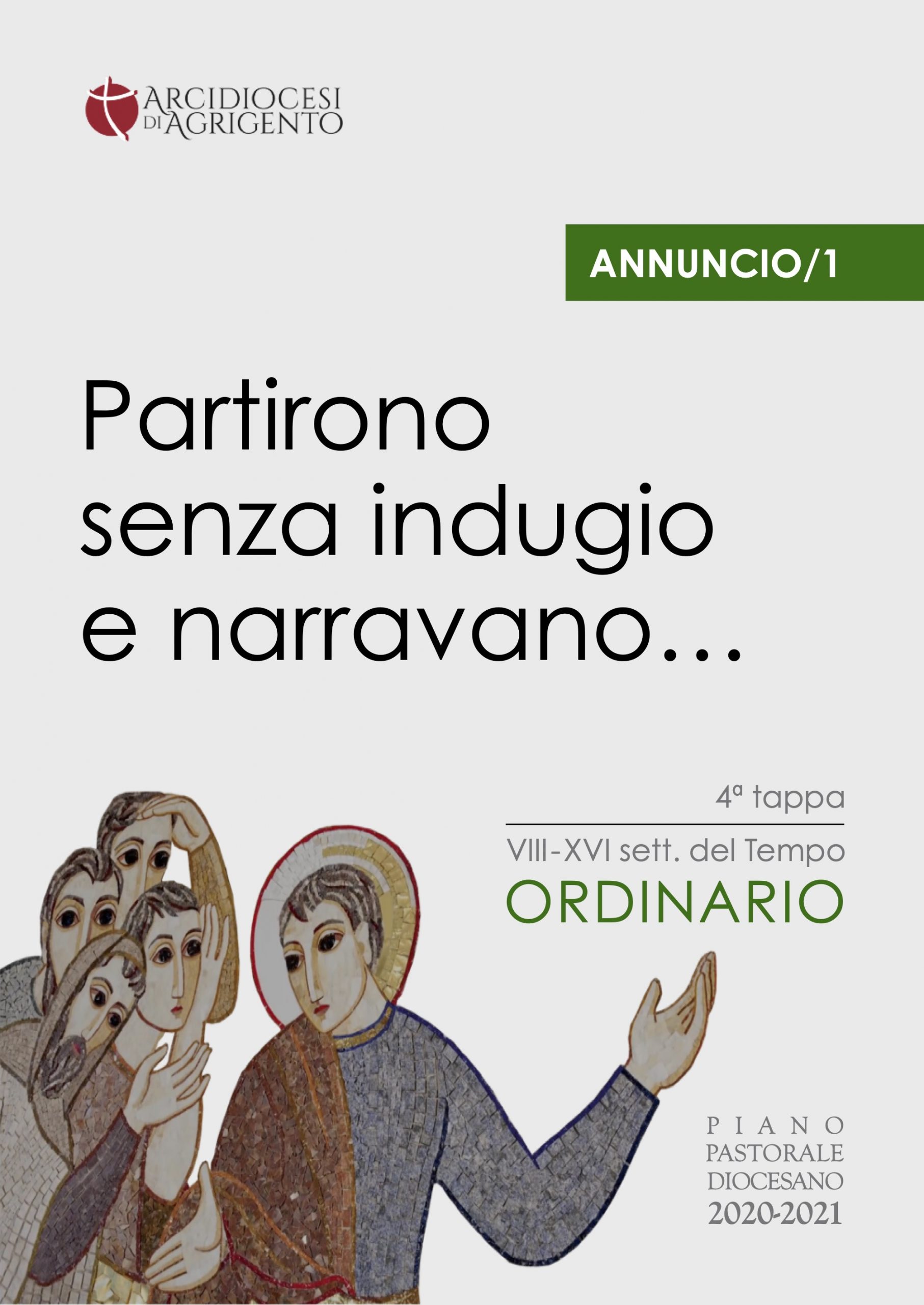
Sussidio-per-il-Tempo-Ordinario-II-1-locandina
Sussidio-per-il-Tempo-Ordinario-II-1-impaginato-per-la-stampa
Sussidio-per-il-Tempo-Ordinario-II-1
Sussidio per la Pasqua (terza tappa)
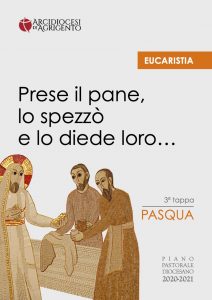
Sussidio-per-la-Pasqua-impaginato-per-la-stampa
Sussidio-per-la-Pasqua-locandina
Sussidio per la Quaresima (seconda tappa)
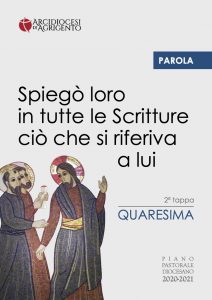
Sussidio-per-la-Quaresima-locandina
Sussidio-per-la-Quaresima-impaginato-per-la-stampa
Sussidio per il Tempo Ordinario [I] (prima tappa / 3)
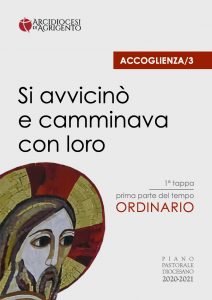
Sussidio-per-il-Tempo-Ordinario-I
Sussidio-per-il-Tempo-Ordinario-I-impaginato-per-la-stampa
Sussidio-per-il-Tempo-Ordinario-I-locandina
Sussidio per il Natale (prima tappa / 2)
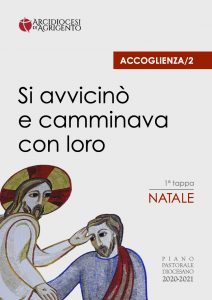
Sussidio-per-il-Natale-impaginato-per-la-stampa
Sussidio-per-il-Natale-locandina
Sussidio per l'Avvento (prima tappa / 1)
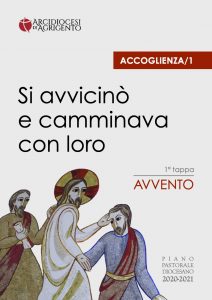
Sussidio-per-l039Avvento-impaginato-per-la-stampa
Sussidio-per-l039Avvento-locandina
Assemblea Diocesana (19.11.2020)